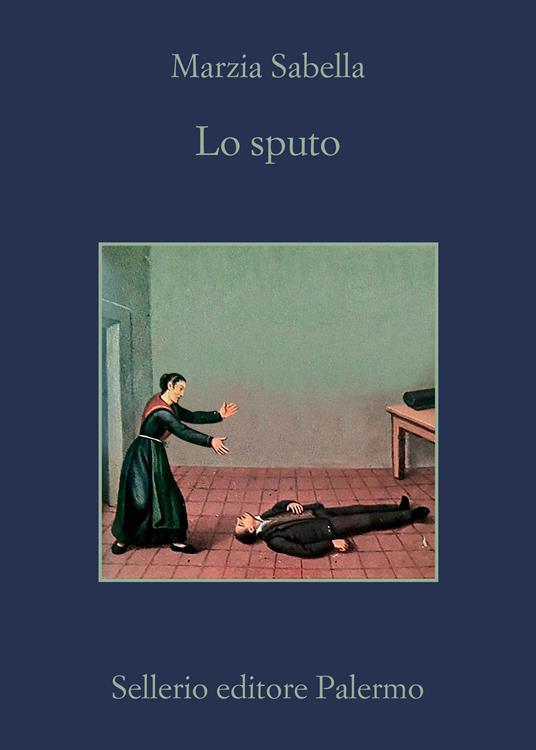Nel 1963, in una giornata qualunque, una donna vestita di nero fino alla testa che lasciava a stento intravedere l’ovale del viso, si era presentata in tribunale di Palermo chiedendo di poter parlare col giudice Cesare Terranova. Aveva stretta al petto una borsa, nera anch’essa, sul fondo della quale (ma allora nessuno lo sapeva e i controlli agli ingressi non erano quelli di oggi) teneva una pistola. Quella donna era Serafina Battaglia. Compagna di Stefano Leale un mafioso di medio livello, titolare di una torrefazione e abitante in via Torino una traversa vicino alla stazione centrale e madre di Salvatore Lupo Leale (del doppio cognome vi dirà l’autrice se avrete, come spero, il desiderio di leggere il libro).
Serafina, detta Finuzza, aveva avuto una vita complicata. Era povera ma era una forza della natura, un carattere forte, determinato che si misurava alla pari con i suoi coetanei maschi. I familiari la fecero ospitare in un convento dove una “donna senza governo” potesse trovare un modo di convivere con le regole di una società arcaica e maschilista che alle donne relegava solo il compito di madre e moglie, meglio se sfatte dalle gravidanze e dall’obbedienza e dal lavoro domestico e nei campi. Per sfuggire alle rigide regole conventuali aveva sposato l’ortolano. Nozze senza amore ne passione finite col durare lo spazio di un mattino. Finuzza conobbe Don Stefano alla torrefazione dove andava a rifornirsi per le esigenze di casa e inscenando col titolare del negozio uno scambio arguto di battute e provocazioni. Non poteva finire come è finita. Serafina Battaglia lasciò il marito e andò a convivere con Stefano, diventando presto la regina della torrefazione, temuta e rispettata. Nel retrobottega dell’esercizio si tenevano riunioni di uomini d’onore, la porta, anche nottetempo, era sempre aperta per accogliere un latitante o per ricoverare armi utilizzate per agguati. Insomma Finuzza si rese presto conto che la sua vita era ben più avventurosa di quanto mai avesse potuto immaginare. Poteva starsene al suo posto, ai limiti imposti dalla tradizione, ma forse anche per la sua condizione di adultera aveva finito con lo spostare un po’ oltre quei limiti, sposando anche le amicizie e i segreti del compagno mafioso, condividendo con lui e i suoi compari scampagnate, sfide al tiro con la pistola, stornelli in cui si prendevano in giro le forze dell’ordine, si insultavano gli “infami” e si inneggiava alla maffia. Spinge il suo uomo a reclamare più potere e a pretendere maggiore rispetto di sé dai capi e gregari dell’organizzazione.
Tutto questo castello comincia a crollare quando il compagno viene sospettato di aver partecipato ad un delitto di un uomo vicino al capocosca Salvatore Greco detto “cicchiteddu”. Serafina riesce a sventare (con modalità che non annoto per non togliervi il piacere della lettura) il primo agguato, ma nulla può contro il secondo avvenuto nei pressi di casa. Muore il compagno e due anni dopo anche il figliolo Salvatore “Totuccio” a 21 anni, cinque mesi meno tre giorni viene assassinato perché sospettato di stare preparando, spinto da Finuzza, la vendetta del padre.
Il cerchio si chiude con l’incontro fra la donna e Cesare Terranova che istruisce il processo e porta alla sbarra le cosche responsabili non solo dei due delitti Leale ma anche di innumerevoli altri omicidi e reati. Ne scaturirono processi tenuti in varie corti italiane (ricorderete che allora si riteneva la Sicilia una terra troppo coinvolta per celebrare i procedimenti e quindi fosse necessario per legittima suspicione spostarli altrove). Serafina Battaglia in quei processi, soprattutto in quello ai mandanti (i Rimi di Alcamo) e agli esecutori materiali fu protagonista in tutti i sensi, conquistò la scena sfidando i boss, insultandoli in maniera mai vista prima e nella bocca di una donna e con l’estremo sfregio di uno sputo pubblico verso chi si era macchiato dell’uccisione di un “picciliddu”, il figlio Totuccio appunto che l’aveva indotta a scegliere la strada della giustizia per vendicarsi e di affidare tutti i suoi segreti al giudice (Giudice Terranova ce n’è uno solo sulla terra. Uno solo. E non offendo a tutti. Come gliel’ho detto, lo dico e lo firmo col sangue…Però onesto come Terranova non ce n’è sulla terra. E noi due possiamo fare battaglia dicendo sempre la verità e con coscienza”.)
In corsivo la trascrizione di una delle risposte che Serafina Battaglia diede al giornalista che la intervistò nel 1967 per una delle più importanti trasmissioni televisive di approfondimento dell’epoca TV Sette.
Fin qui i fatti molto in sintesi. Il libro di Marza Sabella, magistrato che ha lavorato per decenni a inchieste sulla mafia e sui latitanti e che al momento della pubblicazione del libro svolge il compito di facente funzione di procuratore della Repubblica di Palermo, è uno straordinario ritratto di una donna coraggiosa difficilmente definibile con le categorie che in questi anni recenti dell’antimafia si sono sclerotizzate fino a fare perdere la corporeità e la ricchezza di sfumature dei testimoni di giustizia. Finuzza è religiosa e insieme laica, ha eretto un altare a casa sua dove le foto del compagno e del figlio sono accanto alla statuetta della Madonna sofferente con il manto nero del lutto. Non esita a maledire santi e preti. Ce l’ha soprattutto con il parroco che la confina all’ultimo banco della chiesa e le impedisce di comunicarsi e col vescovo timoroso che la “collaboratrice ante litteram” parli troppo della Democrazia cristiana e dei legami che con essa intrattengono i mafiosi alcamesi. “Durante i funerali il prete non accennò all’omicidio, né condannò il gesto dei sicari e rimase concentrato sulla resurrezione…La speranza di una vita nell’aldilà, migliore della presente, un fastello di nuvole e fiori da godere senza fatica, eroicizzava la mano assassina per l’opportunità concessa al defunto pur senza renderne invidiabile la sorte”. Marzia Sabella in poche righe coglie il limite di una Chiesa che per molti anni da allora in poi avrà difficoltà a condannare la mafia come organizzazione a denunciarne alleanze e collusioni. Il libro traccia il disegno di un’epoca oppressa, in cui gli uomini e le donne subiscono i condizionamenti della mafia e della chiesa e in cui la politica non offre ne visioni né speranze e dove (come ben comprese l’organizzazione criminale cominciando proprio nel 1979 la campagna di sterminio di magistrati investigatori e giornalisti e politici che avevano rifiutato di piegarsi) però andava sviluppandosi un fronte di ribellione.
Ma per Serafina che dopo le condanne (degli esecutori) e anche le assoluzioni (dei Rimi) vivrà fino alla fine della sua vita chiusa nel suo appartamento, costantemente minacciata e oggetto di insulti, di scritte ostili sulle mura vicine alla sua abitazione e di lettere anonime che le ricordavano nei modi che potete immaginare che aveva lasciato il marito per scegliere l’amore e la passione (la lussuria diceva il parroco), sempre con la pistola sul cuscino, non ci saranno manifestazioni di solidarietà. Lei stessa si terrà lontana da ogni tentativo di essere accomunata agli altri testimoni (quasi tutti maschi) con i quali non condivide nulla. La sua scelta era stata il frutto di un dolore inestinguibile, la morte del figlio giovanissimo che amava più di sé stessa e che lei vivrà come una condanna definitiva. Non dimenticherà mai di aver spinto il figlio verso il destino di morte istigandolo a preparare una ritorsione tanto inverosimile perché nelle mani di un giovane docile, ben educato, invaghito di una coetanea, dolce, privo delle connotazioni di un mafioso. Marzia Sabella anche ricorrendo a un sapiente intreccio di fatti e invenzioni letterarie e a un linguaggio aderente alla realtà dell’epoca e dei personaggi, crudo e spietato, non cede alla retorica dell’antimafia che dopo le stragi del ’92 si è impadronita della narrazione del crimine e dei suoi protagonisti diventando indigeribile. Ma riporta tutti i personaggi alla loro autenticità costringendoci a fare i conti con la complessità delle sfumature, con le incongruenze e le contraddizioni degli esseri umani. Un libro niente affatto rassicurante che ha tanti meriti non solo “ideologici”. Ha fatto riemergere dall’oblio un personaggio da tragedia greca, dal carattere d’acciaio che aveva trovato la chiave giusta per ricondurre la mafia e i padrini alla loro dimensione con lo sberleffo: “La supremazia della mafia sull’autorità costituita perdeva la sua ragione d’essere nello sberleffo di una donna, e , per di più, per mano di una popolana- scrive Marzia Sabella… Si divertiva, donna Serafina, a ridicolizzare gli uomini d’onore… ci dissi a Totò, levati la coppula di malandrino e mettiti un paru di curnazza ‘n tiesta ch ti stannu cchiù megghiu. Gli e l’ho detto di faccia a faccia, di fronte ai giudici “.
Sboccata, offensiva, coraggiosa “No, non ne ho terrore, niente, niente, niente”. Serafina Battaglia riconquista, grazie al libro di Marzia Sabella, il posto che nella decennale guerra fra mafia, cittadini e istituzioni si combatte contro la mafia. Siamo certi che a lei questo nostro giudizio non farebbe né caldo né freddo, e forse ci gratificherebbe di uno sputo, come quello riservato alla tv che trasmette insulsi talk show sulla mafia che spettacolarizzano il dolore e rendono le persone figurine di cartone da dismettere a fine trasmissione accartocciandole fino alla nuova occasione. Mi piace ricordare a conclusione di questa nota che Marzia Sabella ricorda nel suo libro Mario Francese, il coraggioso cronista del Giornale di Sicilia ucciso nel 1979 in quella stagione terribile alla quale accennavo. Fu proprio Mario Francese a trovare un avvocato che difendesse la Battaglia davanti alla quale tutte le porte si erano chiuse.
Salvatore Cusimano